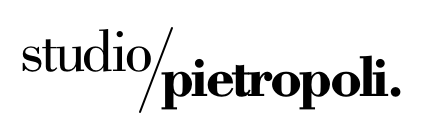Le due rive del grande fiume pensile che attraversa l’ultimo tratto della pianura non fanno presagire qualità molto diverse nei territori retrostanti. Gli stessi grandi argini erbosi gradonati, gli stessi boschi di pioppi piantumati a maglia quadrata, come immense basiliche dalle mille colonne; giù, nel fondo delle scarpate, la campagna nera e fumante, segnata da piccoli gruppi di case e, più lontano, dai campanili.
Ma in quel punto dell’ansa tra Polesella e Ro Ferrarese dove una volta era il ponte di barche e i mulini nell’acqua c’era il confine tra due stati che si fronteggiavano, che avevano leggi diverse, diversa cultura, letteratura e architettura.
Sotto lo stesso cielo orizzontale, nello stesso paesaggio carico di vapori, due comunità hanno interpretato a loro modo lo spazio incommensurabile della pianura dai contorni indefiniti, hanno vissuto l’esperienza della realtà ribaltata sul riflesso dell’acqua del grande fiume, hanno ascoltato le voci vicine ma invisibili delle persone immerse nell’hammam delle nebbie.
Questo stesso ambiente ha dato i natali a due diverse lingue: una priva di asperità, sorta di cantilena nella quale anche la bestemmia veneta diviene musicale e l’altra, quella della sponda ferrarese, piena di “r”, di parole contratte e rovesciate, sanguigna, diretta, bianca e nera come lo stemma della città.
In architettura questi due diversi mondi potrebbero essere descritti come il linguaggio dell’intonaco a fronte di quello ferrarese del mattone faccia a vista.
Quello veneto è un intonaco madreperlaceo scialbato dalla calce con colori pastello e terrosi; le facciate hanno sagome in leggero rilievo, fasce in pietra d’Istria per i davanzali, gli stipiti, i fregi e gli angoli robusti dove c’è bisogno di rinforzo, decorazione leggera in contrasto coloristico.
Il mattone ferrarese può ben essere raccontato dalle parole che André Frossard usa per Ravenna: “Bisogna dire che il mattone ferrarese (ravennate) non è quel materiale insipido con cui il nostro ottocento costruiva fabbriche e officine. E’ una piastra di terra, larga e piatta, che ha conservato qualcosa del fuoco e della sua cottura. Le dimensioni ineguali impiegate con arte formano una serie di ritmi leggermente differenti che si leggono come una poesia muta, fatta di lunghe e di brevi, una sorta di alfabeto morse architettonico. Questo mattone è posato su uno spesso strato di calce che lo mette in rilievo e gli conferisce un valore individuale che non ha in apparecchiature più fitte. Questo mattone, difficile da modellare quanto il vetro, il muratore sapeva Guido Pietropoli
settembre 2005piegarlo in perfetta forma rotonda, in forma di sole sopra le porte, in fughe di archetti, talvolta collocato obliquo ad angoli contrastanti…”
Nell’unica tonalità della cortina muraria le ricche decorazioni in cotto nelle porte ogivali e nelle finestre esaltano la moralità del muro faccia vista; in esso ogni pentimento, ogni errore, ogni ferita è visibile e non può essere nascosta sotto la cortina limbica di un pure preziosissimo intonaco veneto a marmorino.
Ferrara è una città nella quale i voltatesta in pietra bianca, i poggioli d’angolo e le decorazioni a candelabre confermano l’eccesso del cotto che ci conduce in un viaggio metafisico, in una sorta di paese mentale e carnale avvolto in una rappresentazione monocroma.
A Ferrara le carpenterie degli orizzontamenti non sono pacate ed unitarie come la plissettatura continua delle travi a quattro fili della sansovina, ma vi si distinguono vistosamente un’orditura primaria di robuste travi spesso appoggiate su barbacani lavorati e poi un impalcato di arcarecci più esili con tavelle decorate alla maniera toscana.
Altro modo da quello veneto di disegnare il cielo di una stanza prima che a Ferrara si realizzassero i plafoni a grandi lacunari intagliati o, più tardi, gli incannucciati ricoperti di intonaco.
Sono passati a Ferrara tutti gli stili fino al barocco e al neoclassico ma sempre nelle loro declinazioni più austere, più secche, meno inclini a ricercare nel cromatismo della illusione/visione l’effetto di scena fissa della commedia umana.
Le strade e le vie di Ferrara accolgono questo invito all’unità organica di un unico materiale sia nella parte longobarda che nell’addizione erculea; è’ quest’ultimo il più nobile quartiere di una città ideale italiana così come i viali alberati di criptomerie del Daitoku-ji a Kyoto annunciano la nobiltà e l’eleganza di monasteri zen al di là degli impenetrabili muri di calce e paglia di riso.
L’addizione erculea è il sogno di un signore e di un architetto visionari, custodito all’interno del terraglio, catino magico della cinta muraria.
Come aggiungere in questa città e nelle altre cento d’Italia il segno del nostro essere di uomini moderni, razionali, cosmopoliti senza impacci, presuntuosi della nostra dimensione di dominio tecnico orizzontale ma così distanti da un sogno che cerca di accennare a ciò che ci è ormai ignoto? Forse rivelando il palinsesto della storia, grattando le stratificazioni del tempo, ripulendo le incrostazioni, perforando i diaframmi che separano una fabbrica da un’altra per un impossibile viaggio alla Joseph Losey dentro l’architettura dove il continuum di stanze di diverse e lontane fabbriche fa da scena agli accadimenti tragici e giocosi di un Don Giovanni mozartiano?
Forse, ancora, è necessario affidare ai materiali della modernità quali le putrelle di acciaio, alle lamiere degli impalcati, ai colori primari degli smalti chimici l’eloquenza di un linguaggio contemporaneo che solo pochi architetti moderni hanno saputo dominare per accostarsi alla straordinaria carica espressiva dell’architettura del passato?
Davvero impervia la strada di quei pochi che hanno cercato di abbandonare il mimetismo storico, il rifacimento in stile, l’inganno della sagoma antica ricopiata dal manuale, le velature dell’intonaco e le false lavorazioni artigiane.
I nomi non sono molti: il pariniano Franco Albini, Luigi Caccia Dominioni e Carlo Scarpa veneziano, che fece del suo essere ‘dilettante veneto’ la forza che lo preservò da un professionismo mercantile.
Negli anni sessanta/settanta c’era in Italia un ardente desiderio di confrontarsi con il passato, di riappropiarsi dell’architettura della città, di ricominciare a vivere in ambienti depurati dalle passamanerie delle decorazioni a stampo, di vivere il patrimonio storico da dentro, come contemporanei e non come spettatori.
Nel dopoguerra la società italiana, uscita dal ventennio della retorica delle istituzioni e delle magnifiche sorti del progresso, si è rifugiata spesso anche nella ricerca intimistica delle proprie radici domestiche più che in quelle culturali.
Non a caso negli anni sessanta ha inizio anche l’avventura del design italiano che affronta i temi dell’abitare e della produzione seriale di componenti di arredamento.
Alcune ditte del nord d’Italia sviluppano in quel periodo le ricerche avviate dal Bauhaus e quelle più recenti del design scandinavo mettendo in commercio nuovi arredi di grande carica formale ed evocativa.
In questa temperie, sommamente accennata da un punto di vista dichiaratamente parziale, ha inizio il percorso “verso un’architettura” di Giulio Zappaterra, architetto ferrarese appena laureato a Firenze.
Dalla metà degli anni sessanta fino alla sua scomparsa nel 1995 egli ha operato nel campo dell’edilizia residenziale privata e pubblica, nel restauro e riuso di edifici storici e nella progettazione di grandi complessi per l’Università di ferrara e per la cultura.
La sua vicenda professionale può essere letta come emblematica delle condizioni, delle aspettative e delle molte difficoltà che hanno accompagnato il mestiere dell’architetto nella provincia italiana nell’ultimo trentennio del secolo scorso.
Zappaterra inizia la sua attività presso lo studio dell’Ing. Ferrazzi, con il quale progetta alcuni edifici residenziali che si discostano sensibilmente dalla produzione commerciale di quel periodo.
Tra i primi lavori il condominio Fioroni in corso Giovecca, nel quale è evidente il tentativo di comporre una facciata con soluzioni innovative ricercando un dialogo con la quinta stradale di una delle vie più importanti del centro storico di ferrara. Egli fa un uso particolarmente elaborato del parametro in facciavista, vi inserisce decorazioni con cornici in mattoni poste a quinconce, studia effetti materici con fasce di calcestruzzo a vista intercalate; il tutto con lo scopo di accreditare nuovi e vecchi materiali nell’ambiente urbano della città storica.
E’ di quel periodo il progetto del cinema Rivoli, a pochi passi dalla chiesa di S. Stefano nel cuore dei quartieri medievali ed altre esperienze dell’housing che ben manifestano riferimenti culturali e analoghe realizzazioni dell’architettura inglese e scandinava.
Queste due opere di esordio permettono di leggere, in nuce, le tensioni espressive e i primi apparentamenti culturali di Zappaterra ma anche i limiti che una committenza commerciale, e non già il sogno di un principe, era disposta ad accordare.
I riferimenti universitari di Quaroni e Libera, e quelli più labili di Ricci e Savioli, si arricchiscono con la conoscenza di Luigi Alessandri, laureato all’IUAV, come dire dall’altra parte del grande fiume, sul versante veneto.
L’opera di Carlo Scarpa traspare nei dettagli costruttivi e nelle soluzioni d’interni del nuovo e fortunato sodalizio tra i due architetti.
Essi attingono ampiamente alle brillanti soluzioni architettoniche del Maestro veneziano ma sembrano alla fine propendere più verso il lavoro di Gae Aulenti che garantisce loro quell’anonimato ritenuto più consono a un prodotto professionale.
Questa scelta sembra essere vincente ma colloca l’opera di Zappaterra e Alessandri nel flusso dell’attualità, precludendo ad essi la possibilità di sopravvivere alle mode culturali. I particolari architettonici, l’uso di lamiere grecate per i nuovi impalcati negli interventi in fabbriche antiche, un’ampia tavolozza di colori usati per le carpenterie in ferro e per gli intonaci spatolati divengono una sorta di repertorio di soluzioni tipiche che fanno scuola nel restauro critico degli edifici storici a Ferrara. L’intimità domestica ottenuta con saporosi contrasti tra la scatola antica e le nuove tecniche dell’acciaio e del cemento armato si ritrova in realizzazioni quali la sede Carife di via del Gambero; così l’interno di una banca insediatasi in un modesto edificio storico diviene un confortevole soggiorno borghese in cui l’istituto di credito offre un’immagine di sè meno istituzionale e più quotidiana.
Analogamente, il cortile della Banca Nazionale dell’Agricoltura di corso Giovecca viene coperto per divenire una sala del pubblico in cui le colonne in pietra d’Istria e i basamenti sono esibite come una sorta di lapidario privato.
In essa le moderne aperture dei vani scale hanno forma di gigantesca feritoia archibugera per cercare un dialogo con l’edificio, ormai virato alla nuova funzione direzionale.
E’ il sogno di una storia che l’architetto vorrebbe senza interruzioni, senza alcuna lacerazione con il moderno. Ma molte soluzioni formali appaiono mentali, dimostrative, quasi violente e ciò rende difficile nel fruitore una visione equilibrata delle stratificazioni dell’edificio/palinsesto.
Firenze, Venezia e la magica Ferrara sono da Giulio Zappaterra assimilate nel tentativo di recuperare le basi artigianali e fabbrili di un linguaggio contemporaneo che ambisce a rivelare l’identità del contesto urbano.
Questo tentativo è riuscito veramente a pochi, ma dobbiamo essere grati anche a chi, come Zappaterra, ha investigato passaggi stilistici, nuove concatenazioni degli spazi, ha sperimentato inediti accostamenti di forme e materiali.
L’opera di questo architetto ferrarese ha certamente contribuito ad allargare la consapevolezza di una civitas che, forse, non sa ancora sognare la sua nuova identità contemporanea ma che, a noi della riva veneta, piace ritrovare diversa dalle nostre città veneta, così come la storia ci ha consegnato diversi i due territori a nord e a sud del grande fiume.
Pubblicato nel catalogo della mostra Giulio Zappaterra architetto a Ferrara. 1960-1995. Calligrafie fotografiche , marzo-aprile 2006